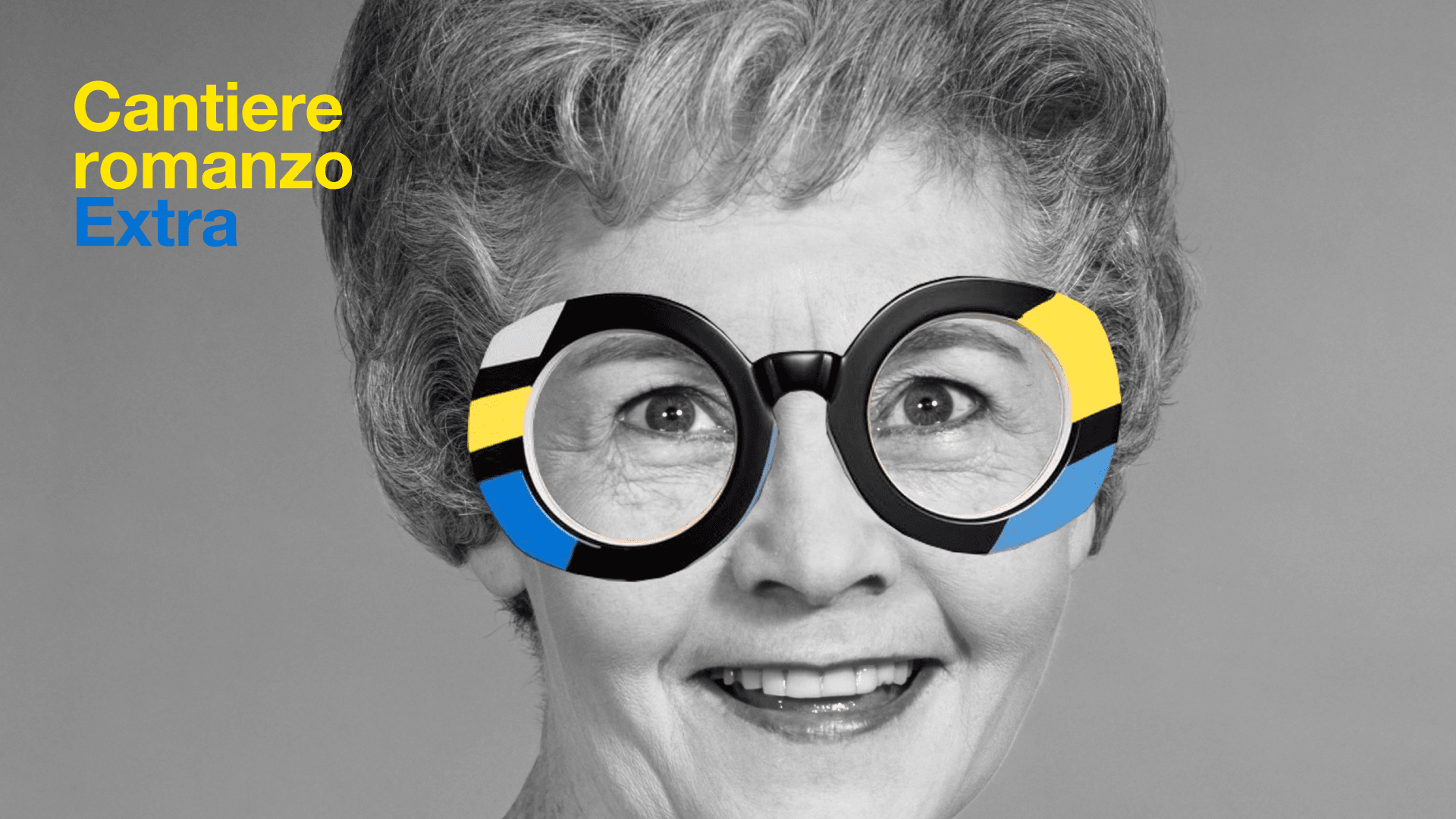Chiara Cerri è la vincitrice della borsa di studio “Cantiere romanzo Extra”. La borsa, promossa da Belleville con il sostegno dell’associazione culturale Pettirosso Cooltureclub, dà diritto a frequentare il corso “Cantiere romanzo” con Silvia Ballestra e un percorso di mentorship finalizzato al completamento e all’editing di un manoscritto che sarà presentato a editori e agenzie letterarie.
Pubblichiamo qui un estratto dal progetto di Chiara, “Corteccia”.
Buona lettura!
***
C’è un momento in cui tutto si spacca in due e nella velocità con cui l’organico decade e la marcescenza diventa vita, ogni cosa sembra dirti che il ciclo è ostinato e si compie più svelto di quanto non potessi pensare.
In quel momento non esiste altro che un lento vagare, in cerca di un posto che sia solo tuo: le bestie stanno con i tendini all’erta; le resine colano dai tronchi; l’odore di terreno e di legna spezzata dei boschi copre quello di cemento e gas delle città; le radici affondano nel sottosuolo.
Quel momento è l’anticamera del principio, in cui aspetti di trovare un territorio dove segnare sopra la tua esistenza, attraverso il tempo e la polvere, finché non diventa indelebile, e la bellezza ti cancella le lacrime.
Perché non ti viene in mente nessun’altra felicità che quella di essere voluti, non esiste altra felicità che quella di appartenersi.
Me le immagino per sempre così, sedute in riva all’argine, strette in un abbraccio, in attesa che la madre quercia dia loro una nuova pelle.
Da sotto il tavolo avevamo la visuale migliore. Lei non se ne accorgeva neanche.
Il pavimento era freddo, ma noi ci mettevamo sopra una coperta, avevamo le sue pantofole logore davanti agli occhi, nella testa il pino selvatico.
Le sue gambe erano nude sotto al vestito, la pelle aveva tanti piccoli nei scuri, arcipelaghi in mezzo all’oceano; solo che il colore delle gambe di nostra madre non era blu, ma rosa chiaro, e il sapore non era salato, ma sapeva di latte. La leccavamo con la fantasia. Ci avvicinavamo per contare i nei con le dita. Due, quattro, nove. Annusavamo la sua pelle Cercavamo di memorizzare. Era poco, ma ce lo facevamo bastare.
La stoffa scendeva dal tavolo un poco alla volta, vista da sotto sembrava non finire mai, come gli alberi che sconfinano nella valle sopra la testa della nostra casa. Invece una fine ce l’aveva, a volte finiva prima a volte durava per un bel po’.
La macchina faceva paura, faceva rumore e si mangiava la stoffa. Lei l’accendeva la sera, quando tornava dal mercato; ci veniva voglia di tapparci le orecchie da quanto era fastidiosa.
Quando tutta la stoffa scompariva, lei si alzava, faceva due passi e poi ricominciava con una stoffa di colore diverso. Erano vestiti, maglie, pantaloni, glieli portavano a casa, lei li piegava e li divideva nei sacchetti, ci appiccicava sopra un nome e una data e li riponeva sulla mensola, quella che noi non potevamo toccare.
Usava sempre il tavolo della cucina per lavorare, perché non ce n’erano altri. Quando mangiavamo dovevamo stare attente a non ingoiare gli aghi per sbaglio.
Lei diceva: «Non vi preoccupate non succede niente, sono come le lische di pesce» e rideva.
La sera intorno alle otto la porta si apriva e ci arrivava addosso, insieme all’aria fredda, l’odore di sigarette e benzina; nel mentre lei si affrettava a radunare le cose sul tavolo.
Santo diceva: «Sono ancora sotto il tavolo quelle due?»
Lei non rispondeva mai, le scarpe di lui si avvicinavano, grumi di terra sul pavimento. L’odore del bar seppelliva il pino selvatico nella testa.
I nostri quattro occhi dietro il gambo del tavolo. Due per una. Il vestito di nostra madre saliva lentamente, la pelle delle sue cosce sotto era ancora più chiara, sembrava quella delle statue di marmo del libro di arte. Ci veniva voglia di infilarci la testa con gli occhi chiusi e dormirci dentro le cosce di nostra madre.
Quando restavamo sole sgusciavamo in piedi, prendevamo un ago e un pezzo di filo, imitavamo i suoi movimenti: prima tra le labbra per bagnarlo e poi dritto dentro la cruna. Facevamo un nodino alla fine del lato più lungo.
Una di noi alzava la mano nell’aria serrando il pollice contro l’indice, come fossero due lembi di stoffa, l’altra iniziava a cucire; sotto la luce della lampada della cucina la nostra pelle sembrava di porcellana. L’una lo faceva all’altra, passavamo ago e filo due o tre volte nell’aria, finché nella nostra testa la nostra pelle non diventava un unico pezzo di stoffa puntato di rosso.
Siamo venute al mondo insieme. Prima è uscita fuori una, e poi l’altra. È una stata una fortuna: così non siamo mai sole. Anche per nostra madre è una fortuna: così non deve preoccuparsi troppo per noi.
Alle volte è talmente distratta che si scorda dei nostri nomi, ci guarda e non sa come chiamarci, allora noi le diciamo:
«Io sono Anja.»
«E io sono Maria.»
«Ti ricordi di noi?»
I nostri nomi non c’entrano niente: Anja è il diminutivo di Anna che viene da Hannáh, significa graziosa, una che ha ricevuto la misericordia. Maria viene da Maryâm e significa afflitta e amareggiata, ma anche amata e cara. Tutto questo ce lo ha raccontato Iolanda, la nostra insegnante speciale.
Chissà perché ci ha chiamate così. Noi non siamo né graziose, né amate, né care.
Nostra madre ha lasciato dietro di sé i campi del sud quando aveva quindici anni, ma era più sveglia di noi, sapeva per esempio, che non bisogna mai voltarsi, se dietro ci sono briciole di pane e botte, così ci ha sempre detto.
È salita al nord per stare con la zia che poi è morta e le ha lasciato un banco al mercato e una casa ai piedi del bosco.
È un pomeriggio di metà agosto quando apre la porta dell’ospedale con due vite nella pancia. Indossa un vestito a fiori, il peso della pancia le impedisce di camminare normalmente, struscia i piedi a gambe aperte. I lunghi capelli neri le cadono sulle spalle.
Tutti quelli che si sono imbattuti nella sua enorme pancia, in quei nove mesi, avevano fatto i loro pronostici: due maschi; anzi no, un maschio e una femmina. Tiravano i dadi: avranno gli occhi verdi tutti e due, uno celesti e l’altra marroni. E il padre? La femmina di solito assomiglia al padre, il maschio alla madre, quindi a te Adele. Lui com’era?
Lui, nessuno l’aveva mai visto.
In quei mesi, qualcuno le aveva anche detto che dalla forma della pancia si capiva che sarebbero stati due gemelli omozigoti, uguali identici.
Lei ascoltava tutti, sorrideva, ma nel profondo era convinta, invece, che sarebbero nate due femmine.
Quando i medici ci tirano fuori per le teste, siamo separate, il cordone ombelicale è uno solo e ci avvolge insieme, ci tirano via una dopo l’altra; ci tengono su per le braccia. Noi urliamo sporche di sangue e placenta; una piange più forte dell’altra; una si dimena più forte dell’altra. Qualche istante dopo qualcosa spegne le luci e si fa buio, dentro e fuori.
Di nostro padre lei non parla mai, non sappiamo neanche il suo nome.
Se le chiedevamo qualcosa, lei ci rispondeva: «Ma come vi permettete bambine impertinenti.»
Se insistevamo, allora si metteva a piangere: «Ah, quindi mi state dicendo che non vi basto io? Volete farmi soffrire?»
Col tempo abbiamo smesso di chiedere, ma non di inventarci la faccia di nostro padre. Sapevamo che era un marinaio, che lavorava sulle barche, ce lo immaginavamo con la pelle bruciata dal sole, la barba bionda e ispida, mentre succhiava un riccio di mare. Mentre baciava in bocca Adele, sul molo, la sera prima di imbarcarsi, e le mani di lei sbattevano sul petto supplicandolo di non andare, noi scalciavamo dentro. Le facevamo sentire tutta la nostra rabbia.
Questo era quello che immaginavamo con la fantasia. Nella realtà c’è stata Manuela, l’amica di nostra madre che lavora anche lei a un banco al mercato, e dalla sua bocca un giorno è uscito questo: «È un bene Ade’ che tu l’abbia scacciato a quello, con tutto il male che ti ha fatto.»
Adele annuiva addentando le pesche marce, tirava giù anche il nocciolo.
Vada è il posto dove viviamo. Non è una città, neanche un paese. Non c’è nelle mappe. Per trovarla devi disegnare sulla piantina un piccolo cerchio col dito, appena sotto le montagne, e a un paio di dita dal mare.
È una valle circondata da versanti puntellati di larici e pini. Ma ormai più nessuno la chiama così, tutti la chiamano la Conca, a causa della sua forma: sembra che con le piogge e il passare delle stagioni la terra sia sprofondata sempre più giù.