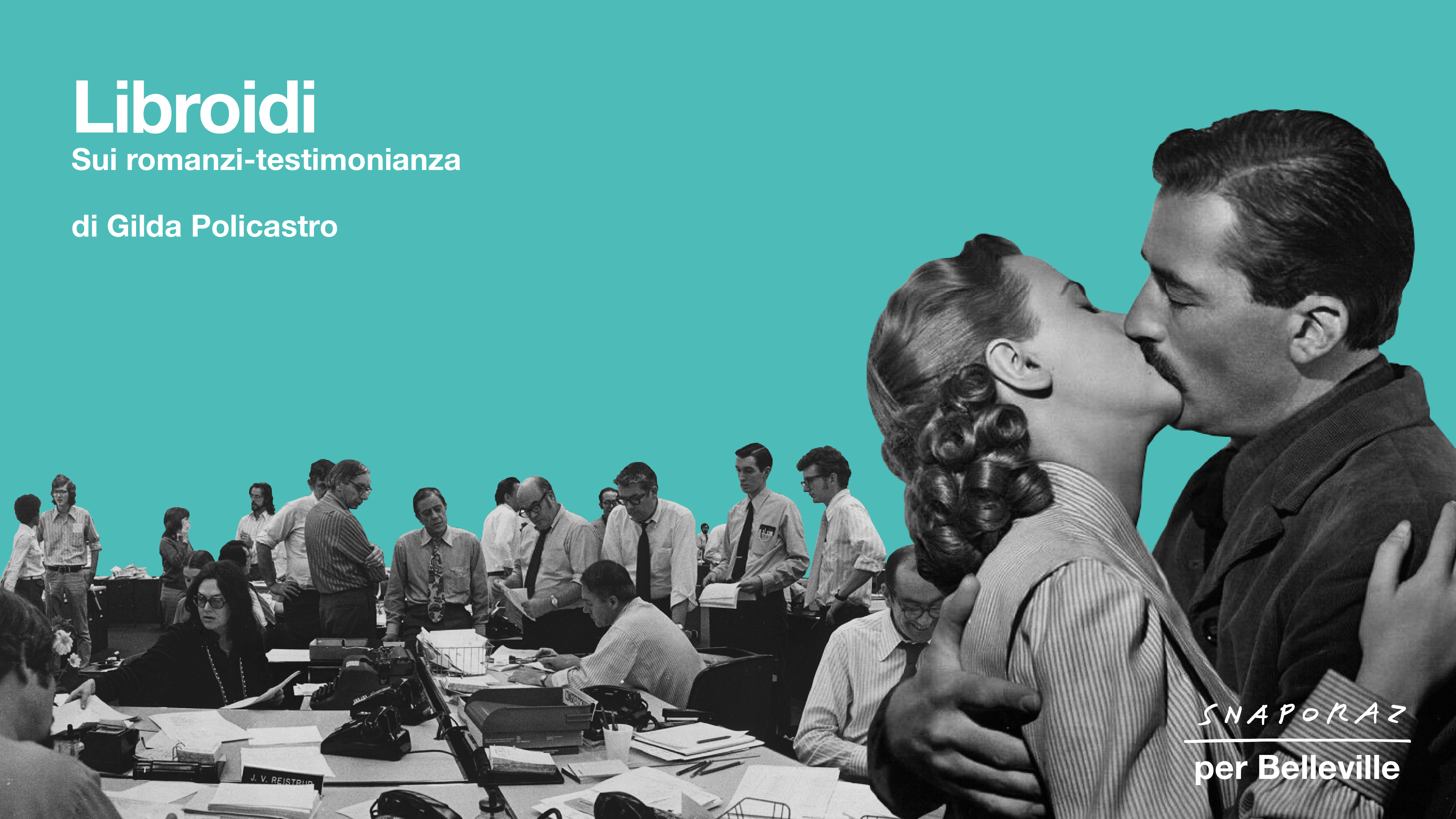Meno sono letterari, i libri, più sembrano volerci spiegare a cosa serve la letteratura, o l’arte in generale. Mi è capitato di recente di leggerne diversi, per un impegno televisivo, di libri scritti da attori, musicisti, registi o consimili, e di trarne la costante pedagogica o euristica. Libri solitamente presentati come “romanzi”, che però ostentavano delle motivazioni esistenziali forti e delle esplicite finalità extra-letterarie (ma allora perché “romanzi”, e non “testimonianze”?).
Il primo caso, e il più (alla lettera) sintomatico, è quello di Elena Di Cioccio, che in Cattivo sangue (Vallardi 2023) racconta i suoi vent’anni di HIV tenuto segreto, ovvero non condiviso con nessuno al netto degli amanti in carica (per un ostentato e talvolta masochistico senso di protezione). Improvvisamente, dunque, un segreto-segretissimo diventa materia esposta alla condivisione indifferenziata: non lo racconto solo alle persone a me care, ma potenzialmente a tutti, o a chiunque. La motivazione sarebbe solidale e pedagogica, appunto: voglio spiegare come ci si sente, voglio riunire attorno a me le persone che hanno lo stesso problema, voglio dimostrare che se ne esce con la forza di volontà.
Funziona anche con libri più letterari, a dire il vero: è il caso dell’ultimo romanzo di Antonella Lattanzi (di cui ho già parlato in questo spazio), o di Maria Grazia Calandrone, già poetessa di nicchia (lo sono, in verità quasi tutti i poeti, se manco uno studente di Lettere saprebbe più fare il nome di almeno quattro o cinque viventi), passata a sponsor delle adozioni in Splendi come vita, suo primo libro in prosa uscito un paio d’anni fa per Ponte alle Grazie, e infine vindice di madri che abbandonano figli, a petto dello stigma morale che le vuole crudeli o spietate. Così nell’ultimo libro, in cui tali madri, proprio in qualità di figlia abbandonata, “comprende e perdona”. Il titolo del nuovo libro (romanzo?), Dove non mi hai portata (Einaudi 2022), rimanda ancora una volta al trauma originario dell’autrice: il suicidio dei genitori biologici nel Tevere, episodio di cronaca del ’64, effettivamente di grande potenziale drammatico e già consegnato a una versione narrativa in un cd allegato al libro L’infinito mélo, uscito per la collana di Luca Sossella Vivavox una dozzina di anni fa. I cd però non si ascoltano più, donde la necessità di riproporne la narrazione romanzesca, in più puntate. Nella seconda, la narrazione ci riporta al Molise dei primi anni Sessanta, dunque a una vita contadina fatta di miseria e ignoranza e all’amore extraconiugale vissuto come forza rapinosa che sfida la morale. La lingua è spesso piegata alle esigenze di accomodamento dell’estremo (il suicidio e l’abbandono di una neonata) entro i pacificati confini del romanzesco, ma la provenienza dalla poesia dell’autrice lascia tracce nella scansione versale di alcuni passaggi, con effetto enfatico, sì, ma anche ritmico: gli spazi sono il respiro della scrittura (e della memoria), e ogni tanto in queste pagine effettivamente c’è aria, rispetto al tono medio e all’asfissia dei drammi borghesi della narrativa egemone. Il libro, tra l’altro, è stato fortunosamente sospinto, nella promozione, da un recente caso di cronaca che ha consentito all’autrice di perpetuare la virtuosa confusione (ormai ovunque accettata senza alcuna riserva etica) tra marketing e adesione alle cause sociali à la page. D’altra parte una delle insegne del libro è proprio l’esemplarità della vicenda, con intenzioni e tonalità emotive empatiche, che sconfinano nell’adesione creaturale talvolta lievemente mitomane (“Mi sento vita di tutti”).
Anche Di Cioccio, tra un capitolo e l’altro, rivendica l’importanza della funzione testimoniale e affratellante della letteratura, e d’altra parte il suo libro ricalca (non saprei dire quanto consapevolmente) il precedente Febbre, scritto da Jonathan Bazzi alcuni anni fa, con tanto di giovinezza rozzanese in comune (“Rozzangeles”).